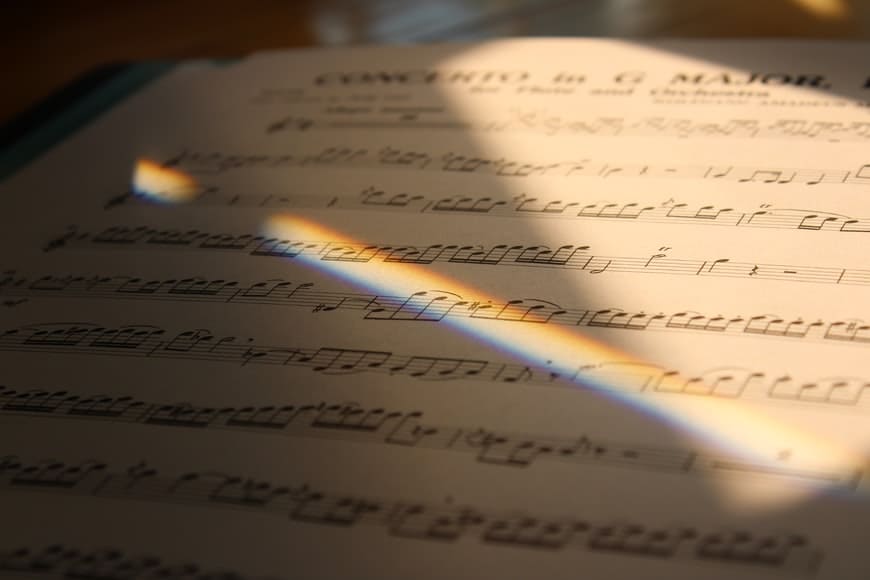di Stefano Jacoviello
David Bowie moriva il 10 gennaio del 2016. Questi sei anni sono serviti a molti fra critici e semplici ascoltatori per capire che l’artista pop reputato un “songwriter”, come tanti nella sua categoria, fosse in realtà un compositore. Ovvero, piuttosto che applicare formule e soluzioni stilistiche condivise, anche rielaborandole in maniera estremamente originale, Bowie ha inciso sulle forme espressive del discorso musicale del suo tempo, aprendo la sua scrittura a riletture future sempre prolifiche e fruttuose. È già successo con figure come George Gershwin o Cole Porter, autori di idee musicali ben più fertili di ogni prodotto concluso che le conteneva, e che pure aveva già raggiunto notevole successo con gli artisti ancora in vita.
Visitatore e riscrittore di molti generi che intessono l’universo sonoro della popular music, Bowie aveva terminato la carriera e l’esistenza flirtando con il jazz di Maria Schneider e le sonorità di Kendrick Lamarr che innervano il suo ultimo album Black Star. Come poter mai dimenticare gli accordi orchestrali carichi di tensioni sullo sfondo del toccante melologo che è di fatto un testamento e un messaggio d’addio: «Sue, the clinic called, the x-ray’s fine, I brought you home, I just said home».
Era quindi naturale che il jazz – non un genere, ma un modo di intendere la musica figlio della modernità del Novecento – avrebbe raccolto il testimone e cominciato ad aprire le composizioni di Bowie per portarle altrove, in un tempo e suono altro.
È successo ovviamente nella “sua” Gran Bretagna, dove i tributi sono sembrati però piuttosto disorganici, di qualità discontinua e limitati a singole “cover”, alcune delle quali raccolte nell’album Modern Love (BBE, 2021).
Ma è successo anche in Italia, dove qualche anno fa Enrico Rava aveva già sorpreso i jazzofili ancora incappottati nei jazz club con un album dedicato a Michael Jackson, mentre il pubblico della classica, talvolta un po’ meno infeltrito, era stato svezzato dal pianista Maurizio Baglini che all’indomani della scomparsa del Duca Bianco terminava felicemente i suoi recital beethoveniani con una sua versione di “Life on Mars”.
Nell’anno appena trascorso ancora funestato dalla sospensione della vera vita musicale, per celebrare la ricorrenza della sua scomparsa sono usciti dall’area vasta del jazz italiano due album che hanno rispettivamente riletto e riscritto Bowie.
Il primo, Heroes Expanded (A tribute to David Bowie), è nato sotto le insegne della Tǔk Music, meritoria etichetta di Paolo Fresu che con tromba, flicorno ed elettronica ha giocato un ruolo importante in un’impresa che coinvolge alcuni fra i migliori esponenti della nuova generazione di jazzisti italiani: Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli – già attivi con Rava – con la funambolica voce di Petra Magoni, supportata dalla giovane figlia Frida Bollani Magoni, e il batterista Christian Meyer, storico membro di Elio e le Storie Tese.
La compagine di tutto rilievo scava nelle forme delle canzoni di Bowie per ritrovarvi affinità con altri mondi musicali e fratture in cui innestare l’improvvisazione. Come era possibile attendersi, spunta qua e là l’ombra del Miles Davis che faceva i conti con la Cindy Lauper di “Time After Time”. Il trombone multiforme di Petrella, sempre sorprendente, mette a frutto tutte le possibili intersezioni con l’elettronica, mentre la chitarra senza costrizioni di Diodati apre un varco fra i recinti di genere e porta sapientemente l’irruenza emotiva del rock nelle architetture armoniche e ritmiche più raffinate. Heroes Expanded riserva a Bowie il trattamento che il jazz solitamente dedica ai songwriter: la conseguenza inevitabile è l’emergere delle qualità dei singoli su un tessuto musicale appositamente straniato, che offre a ciascuno l’occasione per mettere in gioco la propria perizia tecnica e sensibilità artistica. Si tratta di rileggere collettivamente un testo, con la forza istantanea e simultanea di una conversazione in cui le voci dialogano, si sovrappongono, si incastrano e talvolta si discostano l’una dall’altra, per dire qualcosa di se stesse.
Tutt’altra è l’impostazione di Izarus, l’altro progetto prodotto dall’etichetta Mordente. Qui a condurre la sfida è la talentuosa Serena “Armstrong” Fortebraccio, cantante, autrice e polistrumentista, che conferma la sua lucidità nell’accostarsi al lavoro di giganti della musica d’oggi già dimostrata con il lavoro su Björk, In shape of a girl, del 2016. Con i suoi Moonwalkers, più che rileggere, Fortebraccio opera una vera e propria trascrizione, andando a rivelare con le sue intonazioni i molti accenti che la musica di Bowie è ancora in grado di esprimere. Rispetto agli episodi chiusi del disco di Fresu, pur aggirandosi più o meno intorno agli stessi titoli, Izarus si presenta compatto, con l’organicità di un’indagine sentimentale che porta in primo piano una visione non solo sulla musica, ma sull’arte intera e poliedrica di Bowie compresa attraverso le sue canzoni. Gli arrangiamenti del percussionista Fabio Accardi costruiscono un ordito che i suoni della chitarra di Alberto Parmegiani, il piano e le tastiere vintage di Domenico Cartago e il contrabbasso di Giorgio Vendola contribuiscono ad orientare nello sguardo sull’eredità di una cultura pop da recuperare con attenzione.
Izarus è un avvincente monologo in cui, brano dopo brano, l’artista inglese sembra tornare a parlare attraverso la voce di Fortebraccio, che talvolta la sopravanza mascherata dai filtri elettronici. Come quando recita alcuni versi da Howl di Allen Ginsberg per fare da prologo a “This is not America”, aprendo lo spazio per un dialogo fra personaggi di un dramma interiore. È un gioco di riflessi allo specchio quello fra Bowie e Fortebraccio, un corpo a corpo sonoro che finisce per coinvolgere l’intimità dell’ascoltatore reso partecipe delle visioni evocate. L’efficacia delle soluzioni poetiche di Bowie si rinnova nelle riarmonizzazioni e le poliritmie a contrasto con la viva memoria dell’originale, portando l’ascoltatore a ricantare interiormente ogni parola per apprezzarne inattesi reverberi di senso.
Strano procedimento la trascrizione musicale: permette di ricordare ancora un autore a patto di poterlo dimenticare, regalandogli l’eternità al di là di se stesso. A Bowie, che ha cambiato identità e universo sonoro più volte durante tutta la sua carriera artistica, forse sarebbe piaciuto molto essere dimenticato così.